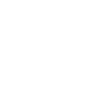L’italiano si chiamava Giulio Natta (1903-1979); laureato in Ingegneria chimica al Politecnico di Milano (1924), aveva fatto carriera a Pavia, Roma e Torino. Nel 1938, a seguito delle leggi razziali, il docente di Chimica industriale al Politecnico milanese, Mario Giacomo Levi (1878-1954), era stato allontanato; gli era subentrato Natta.
Alla fine della Seconda guerra mondiale si era convinto che bisognava far tesoro dell’esperienza tecnico-scientifica dei vincitori, e con l’amico Piero Giustiniani nel 1947 si era recato per due mesi negli Usa, rendendosi conto dei grandiosi sviluppi nel settore petrolchimico raggiunti oltreoceano. Anche lui ingegnere, al ritorno in Italia Giustiniani era diventato amministratore delegato della società Montecatini, fondata nel 1928 e leader nel nostro Paese per la lavorazione dei minerali e la produzione del nylon; aveva approfittato dell’occasione per mettere a disposizione di Natta fondi e attrezzature per fondare a Milano un centro di ricerca macromolecolare.
Era stato il tedesco Hermann Staudinger (1881-1965) a utilizzare il termine macromolecola nel 1920, con l’idea che le varie sostanze che mostravano elevati pesi molecolari fossero composte di lunghe catene di unità identiche, che si ripetevano in modo continuo. Per indicare queste peculiari sequenze doveva imporsi anche la locuzione polimeri, benché la parola fosse stata introdotta originariamente nel 1833 dal chimico svedese Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) per denotare altri composti. Pur attraverso dure polemiche, il punto di vista di Staudinger aveva ottenuto successo, e soprattutto negli Usa la chimica dei polimeri aveva conosciuto una rapida evoluzione, grazie a un’industria illuminata che si era resa conto delle possibilità applicative delle sostanze sintetiche. Infatti, benché a rigore anche le macromolecole tipiche dei sistemi viventi — proteine, acidi nucleici, acidi saccarici — siano polimeri, con il termine si indicano soprattutto macromolecole costruite in laboratorio: materie plastiche, gomme sintetiche e fibre tessili come il già citato nylon, nonché i polimeri biocompatibili impiegati dalle case farmaceutiche.
I risultati di Natta e della sua équipe — un misto di rigore e serendipità — avevano consentito la produzione su larga scala di nuovi materiali polimerici, tra cui quel propilene isotattico destinato a diventare celebre come Moplen. Nel 1963, dieci anni dopo il «maestro» Staudinger, che aveva conosciuto nel 1932, Natta doveva ricevere il Nobel insieme a Karl Ziegler (1898-1973), con il quale aveva direttamente collaborato.
L’infatuazione del pubblico e l’entusiasmo dei politici nostrani per i polimeri di Natta non dovevano durare a lungo. Ancora una volta, nonostante la presenza di un’eccellenza scientifica che spesso il mondo ci invidia, l’Italia non è riuscita a diventare — come osserva Pivato — un Paese trainante, a livello istituzionale, di una globale «società della conoscenza».
Ciò è particolarmente vero per la chimica, a proposito della quale si è consolidato, sul finire del Novecento, lo stereotipo di una disciplina «responsabile degli aspetti negativi delle società industriali, dall’inquinamento alle piogge acide, dall’adulterazione degli alimenti alla preparazione di droghe e veleni. Questa visione è il frutto della diffidenza secolare che un umanesimo di vecchio stampo nutre verso la scienza e che porta a guardare con sospetto alle conquiste scientifiche, nel timore che esse possano orientare lo sviluppo della società verso una forma di potere dei tecnici capace di condizionare la libertà e l’umanità delle società future».
Così Salvatore Califano, professore emerito di Chimica fisica all’Università di Firenze, apre la sua Storia della chimica in due volumi (Bollati Boringhieri), che ricostruisce le vicende della disciplina dall’antica alchimia alla chimica odierna.
Il nome chimica indicava nell’antichità l’arte di trasformare i metalli comuni in oro e argento; più in generale, forse a essa più che a ogni altra attività umana, si potrebbero adattare i versi dell’Antigone di Sofocle, per cui «nulla è più terribile dell’uomo», proprio perché egli si mostra capace di piegare la natura ai propri scopi, salvo poi venire castigato dagli dèi per la sua tracotanza.
La plastica — che oggi nessun Bramieri celebra più — come destino? E il chimico odierno vestirebbe solo i panni di un cattivo dottor Faust, ben più temibile di qualsiasi vecchio alchimista sprofondato tra storte e alambicchi, oggetto di facile scherno per qualsiasi Mefistofele di passaggio? Se la fisica, con il potere racchiuso nell’atomo, ha agitato lo spettro della distruzione planetaria, la chimica non potrebbe inquinare il nostro corpo e persino la nostra mente come già inquina l’ambiente esterno con le sue mefitiche «puzze»?
Eppure, tutti coloro che vorrebbero fuggir via dalla «maledizione della chimica» dovrebbero avere almeno il coraggio di rinunciare non solo a farmaci e computer, ma persino ai film d’evasione o alle sgargianti camicie colorate.
Come scrive Califano, la storia della chimica coincide «col racconto della liberazione dell’umanità dalla fame, dalle malattie e dal dolore», e dunque con la storia stessa della civiltà.
«La nascita e la crescita della struttura industriale e le trasformazioni sociali che ne sono derivate sono infatti strettamente collegate con lo sviluppo della chimica e ne riflettono l’evoluzione storica e i cambiamenti concettuali, le contraddizioni e le conquiste».
Da buon dialettico, Califano evoca il fuoco di Eraclito, principio di ogni trasformazione, immagine di una realtà «che si riposa muovendosi»; ma non è questione di destino, bensì di coraggio, libertà e responsabilità. Il lettore ritroverà l’avventura intellettuale di una disciplina che si è svincolata dal «sapere sacro» dei primi cultori delle «arti del metallo», per dirla con Mircea Eliade, e ha costituito un caso esemplare di laica conoscenza cresciuta attraverso la capacità di creare artificialmente nuove «nature», combinando le leggi di quella natura a cui noi stessi apparteniamo.
Ma è anche la storia dei chimici, un tempo perseguitati come apprendisti stregoni, poi ghigliottinati dal potere rivoluzionario come Lavoisier, costretti al silenzio o alla fuga sotto i totalitarismi di Hitler o di Stalin, o condotti alla morte dal male oscuro della depressione (come capitò a W.H. Carothers, l’inventore del nylon); ma sempre capaci di aprire nuovi varchi alla libera immaginazione.
Come scriveva uno di loro, il britannico Cyril N. Hinshelwood, Nobel nel 1956, i chimici cercano di scoprire «le cause nascoste, che sottendono i cambiamenti del mondo», e la percezione di tali meraviglie è «un’esperienza estetica». Forse, un’esperienza che certi esteti di professione stentano a capire.
Giulio Giorello, “Non sparate sulla chimica”, pubblicato sul Corriere della sera
6 maggio 2012